Corruzione, una rapina da 60 miliardi ogni anno
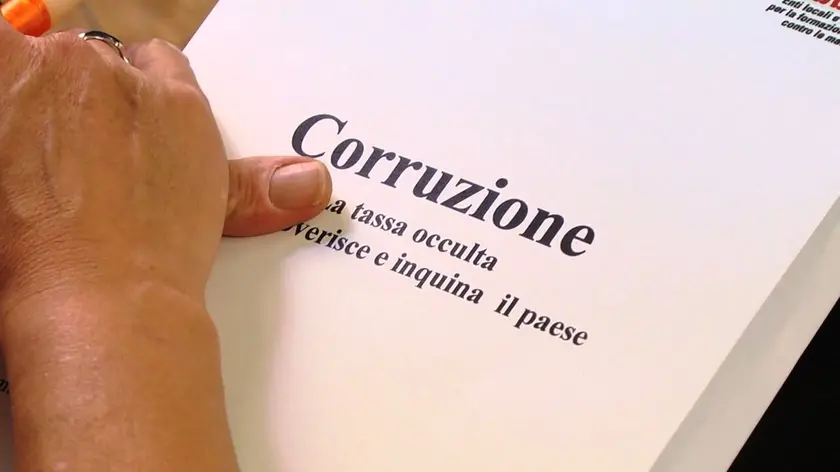
ROMA. La corruzione costa al nostro Paese 60 miliardi di euro l’anno, cifra ufficiale calcolata dalla Corte dei Conti. Significa che per ogni cittadino italiano (neonati compresi) è prevista annualmente una vergognosa tassa occulta di mille euro. Poi ci sono i costi non monetizzabili, quelli che riguardano la devastazione dell’immagine e della credibilità della nostra economia, con conseguente inesorabile allontanamento degli investitori stranieri. E ancora, le rovinose ricadute sul nostro futuro, su quello dei giovani, con crescente sfiducia nella capacità delle istituzioni di operare per il bene comune.
La corruzione è una pratica purtroppo abituale, non riconducibile a un circuito delimitato per quanto esteso. Si tratta sempre più di un vero e proprio sistema. Per contrastarlo occorrono regole rigorose, non confuse e annacquate (come quelle attualmente in vigore), che riescano a rendere la corruzione non conveniente. Sia attraverso la definizione delle fattispecie penali, sia attraverso adeguate sanzioni (le interdittive sono le più deterrenti) e la certezza della pena. Inoltre, poiché la corruzione è un fatto “interno” che si tende a tenere nascosto, è di decisiva importanza rompere questo sistema incentivando forme di “pentimento”, di collaborazione con la giustizia, che incidano sullo scellerato patto di solidarietà tra corruttore e corrotto.
Utilissimo può essere l’impiego di agenti provocatori, come si fa ad esempio per il traffico di droga, reato di gravità almeno pari alla corruzione. Servirebbe introdurre anche nel nostro ordinamento, con idonee gratificazioni, figure come i “whistleblower”, cioè suonatori di fischietto o vedette civiche capaci di segnalare e denunziare ciò che conoscono. Invece niente di tutto questo: la nostra politica continua a baloccarsi, a colpi di sofismi e veti incrociati, in buona sostanza ritardando - almeno fino a oggi - ogni tentativo (anche i meno audaci) di dettare norme più rigorose contro la corruzione. L’obiettivo deve essere quello di combattere la corruzione disciplinando l’attività pubblica sul versante economico come una casa di vetro protetta da porte blindate. Prevedendo anche test di integrità per politici e amministratori, e non esitando a mettere fuori gioco chi abbia gravemente o reiteratamente sbagliato.
Senza mai dimenticare che la corruzione non è soltanto questione di guardie e ladri, di delinquenti ed organi istituzionalmente chiamati a reprimere i reati. La corruzione è anche, se non soprattutto, impoverimento della comunità di cui ciascuno di noi è parte. Perché ci rapina risorse, che se invece le avessimo sicuramente vivremmo molto meglio.
Papa Francesco ha interpretato mirabilmente questi sentimenti con parole forti. I corrotti sono «putredine verniciata, devoti della dea tangente». La corruzione è «non guadagnare il pane con dignità», per cui ai figli dei corrotti tocca «ricevere come pasto dal loro padre sporcizia». Sprezzanti la parole del Papa sulle nefaste conseguenze delle «cricche della corruzione, che con la politica quotidiana del “do ut des”, dove tutto è affari, producono ingiustizie che causano sofferenza». Chi paga per questo? Sostiene il Papa che «pagano gli ospedali senza medicine, i malati che non hanno cura, i bambini senza educazione».
Questi alcuni esempi di impoverimento causato dalla corruzione, una delle declinazioni della illegalità economica (altre sono l’evasione fiscale, che ci costa 120 miliardi di euro l’anno; e l’economia mafiosa, un business da 150 miliardi annui). È quindi evidente che ogni recupero di legalità, a partire dalla corruzione, è un recupero di reddito che ci conviene. La legalità è la strada giusta per affrontare i problemi economico/sociali che ancora ci affliggono. È la chiave per avviare percorsi di sviluppo economico ordinato, senza più costanti penalizzazioni per chi ha maggiore bisogno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








