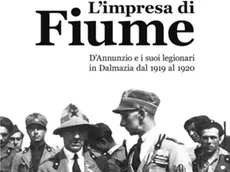«D'Annunzio? Il grido “A noi” è retorica, non anticipò il fascismo»

UDINE. «Professor Sereni, per l’Anpi e la sinistra Fiume non è altro che l’anticamera del fascismo, un atto di ostilità capace di infiammare i Balcani e quindi un periodo magari da ricordare e non celebrare. Cosa ne pensa?».
«Per l’amor di Dio. E poi all’epoca non la pensavano così Gramsci e Bordiga, che qualche cosa per la sinistra contano».
Il professor Umberto Sereni, lucchese e per oltre vent’anni docente di Storia contemporanea all’Università di Udine, studioso di lunga data proprio degli anni post Grande guerra in Italia, non è affatto convinto di ridurre l’impresa dannunziana a un atto di aggressione, da dimenticare e persino da condannare.
Eppure l’espressione “A noi”, quei manganelli usati dalle milizie a Fiume, l’olio di ricino, fanno pensare ad altro.
«Retorica o poco più, se il grido “A noi” è stato mutuato dalla Reggenza del Carnaro dal fascismo non vuol dire che quell’esperienza in Istria sia stata il prodromo dei vent’anni bui per l’Italia. Anzi. La Reggenza del Quarnaro, ad esempio, fu uno dei pochissimi stati a riconoscere la neonata Unione Sovietica.
Il ministro degli esteri sovietico Cicerin aveva rapporti costanti con Gabriele D’Annunzio. Considerava l’esperienza a Fiume elemento di rottura fondamentale contro l’imperialismo di Francia e Inghilterra uscite vincitrici dalla Grande Guerra».
Si lamenta anche l’ambasciatore della Croazia però per queste celebrazioni...
«Ma andate a vedere chi erano quei “rivoluzionari”...»
Ce li descriva.
«Erano innanzitutto giovani, tanti giovani, espressioni delle più diverse realtà politiche italiane ed europee. Gente uscita delusa dalla Prima guerra mondiale, che voleva cambiare il mondo, piena di energia. Tra i dannunziani c’era di tutto. Era un movimento per antonomasia più antifascista dei fascismo».
Mussolini come reagì alla roboante iniziativa del poeta?
«Male. Fiume è una cesura netta nel rapporto tra il futuro Duce e il grande poeta. Mussolini teme l’azione di D’Annunzio. Al momento della fine della reggenza nel dicembre del 1920 abbandona repentinamente il poeta al suo destino defilandosi.
Diceva apertamente: “Lasciate perdere Fiume, quelle sono cose da poeti”. Ripeto: il fascismo riprese la retorica di Fiume ma non la sostanza, verrebbe da dire...magari l’avesse ripresa la sostanza».
Ecco, la sostanza: cosa fu la Reggenza del Quarnaro ?
«A Fiume c’era un’idea di libertà. Un’idea di Italia nuova, libera, che affascinò, ad esempio, un socialista come Alceste De Ambris, difensore dei diritti dei cittadini e più a sinistra della sinistra. Il messaggio politico che lanciò la Reggenza era forte. Tra i dannunziani c’era Giuseppe Di Vittorio, che poi sarebbe diventato il capo del socialismo italiano».
Insomma, Fiume fu l’espressione della voglia di nuova vita.
«Sì, che diventò la Carta del Quarnaro, dove musica, cultura, formazione dell’uomo avevano una grande importanza, ma i cui cardini erano l’uguaglianza sociale, il voto alle donne, la tutela del lavoro. Insomma, non certo una cosa da dimenticare, ma da ricordare. Magari da non celebrare, ma sicuramente come da ricordare come una pagina della storia tutt’altro che marginale».
Il finale fu amaro per D’Annunzio.
«Il poeta fu tradito da Mussolini, questo è sicuro. Mussolini si accordò con il primo ministro Giolitti che si sbarazzò dell’impresa di Fiume e in cambio diede all’interlocutore l’inserimento nel Blocco Nazionale dei candidati fascisti. Le navi della marina cannoneggiarono la città e quell’esperienza finì rapidamente».
Per il poeta iniziò così l’esilio dorato del Vittoriale.
«Anche se D’Annunzio, nonostante l’età che avanzava, non smise mai di essere critico nei confronti del fascismo. Il Duce sapeva che il poeta era nel cuore degli italiani, e sapeva che per questo D’Annunzio era intoccabile.
C’è un episodio poco ricordato ma emblematico nel rapporto tra i due. Nel 1942, quando la situazione della guerra era ormai diventata critica, Mussolini convocò a Milano i rappresentanti delle province e ai lombardi ricordò come vent’anni prima il poeta era stato sul punto di anticipare l’esplosione del fascismo.
Era vero. Il ministro Facta aveva convocato nella capitale D’Annunzio poco dopo la Marcia su Roma delle Milizie fasciste. L’idea era quella, in occasione del discorso del 4 Novembre, di far prendere al poeta le redini della Nazione intercettando quel malcontento popolare che si stava indirizzando verso il fascismo».
Insomma, Mussolini avrebbe potuto essere anticipato sul tempo dall’autore dell’impresa di Fiume...
«Esattamente. E in fondo quello che il Duce temeva nei primi anni del Regime. Poi, confinato nell’esilio dorato del Vittoriale, il Duce finì per essere un problema e fu solo sopportato».
Si è mai chiesto che Italia sarebbe stata con D’Annunzio a guidare gli Italiani?
«Certo. D’Annunzio non era un politico, ma un poeta. Le sue idee, certamente rivoluzionarie e tutt’altro che di estrazione fascista, sarebbero durate poco. Ma una cosa è certa, quell’impresa di Fiume deve essere ricordata, eccome. Piacque anche ai padri della sinistra e del sindacalismo, vorrà pure dire qualche cosa». —
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto