Fuga con i coreani da Mogadiscio, l’ambasciatore Sica ricorda la Somalia del 1991
Nel kolossal di Ryoo Seung-wan l’ex diplomatico italiano in Namibia è interpretato da Enrico Ianniello
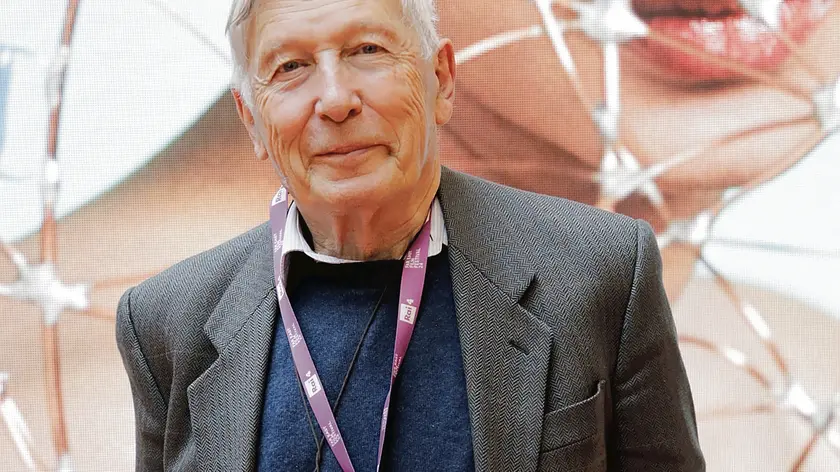
L’ex ambasciatore italiano a Mogadiscio Mario Sica, ospite del Feff, ha ricordato la fuga dei consoli coreani (Foto di Riccardo Modena)
UDINE. Prima di svegliarsi a Mogadiscio nell’epicentro dell’insurrezione l’ambasciatore italiano Mario Sica, col placet del governo, acquistò un caste
Articolo Premium
Questo articolo è riservato agli abbonati.
Accedi con username e password se hai già un abbonamento.
Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop
Non hai un account? Registrati ora.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto
Leggi anche
Video








