La proposta: «Rifare l’alleanza di 40 anni fa per salvare la montagna»
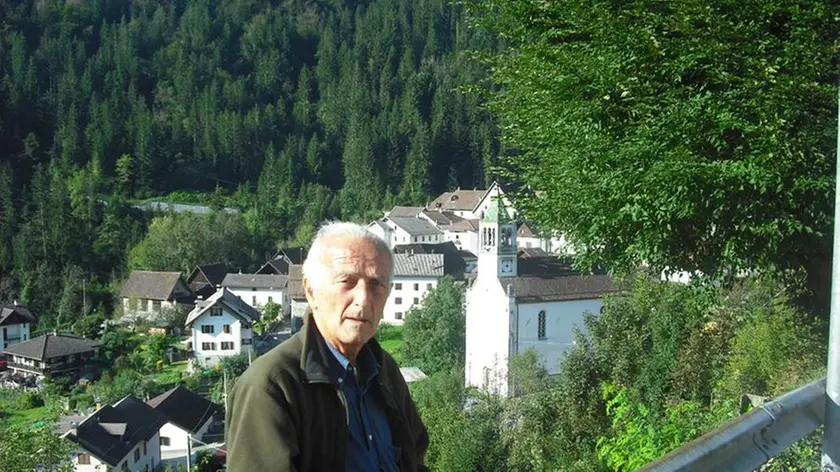
UDINE. Rifiuta il modello Friuli, preferisce parlare di esperienza Friuli, rispolverarla e attualizzarla per affrontare i problema della montagna, la zona fragile alla destra e alla sinistra del Tagliamento ,che nel 1976 fu distrutta dal terremoto.
Giulio Magrini, un carnico fedele alla sua terra, quarant’anni fa era un giovane consigliere regionale del Pci, eletto nel collegio di Tolmezzo.
A celebrazioni del quarantennale concluse, il politico d’altri tempi accetta di parlarne, esce dagli schemi e promuove il ruolo svolto dai partiti.
Suggerire alla sua gente di ricostituire l’alleanza politica che fu determinante nella rinascita del Friuli, per dare una risposta allo spopolamento della montagna, alle difficoltà del turismo e all’economia che continua a rallentare.
«Penso a una grande intesa nell’analisi, nella gestione e nel controllo, poi spetta alle istituzioni, alla Regione, alle Uti e ai Comuni, dare un po’ di dignità alle parti politiche. In questo modo eviteremo che «lo spontaneismo diventi ribellismo verbale, inconcludente».
Magrini prova a gettare un seme in un momento delicato tanto quanto lo era nel 1976. Allora la Regione a statuto speciale a guida Dc, aveva pochi anni e il terremoto distrusse la zona più debole, da Cassacco o poco prima alla Carnia.
«Ci rendemmo subito conto che la tragedia era imponente e che aveva colpito la zona economicamente più fragile». Le parole di Magrini rivelano la preoccupazione con cui i politici di allora decisero di mettersi alla prova per «fare le cose bene, nei tempi ragionevoli, assumendo un atteggiamento sobrio e convinto».
Erano gli anni dei «partiti di massa, organizzati, che prestavano molta attenzione nei confronti della Regione che finalmente avvicinava il potere ai territori trascurati per anni dai governi nazionali». Erano gli anni, continua, in cui «il rapporto fra i partiti e i consiglieri regionali era intensissimo e continuo».
La distruzione portò tutti i rappresentanti politici a dire: «L’unica soluzione è ricostituire una specie di Cnl della zona terremotata. Un Cnl aperto anche la Movimento sociale. Nei momenti difficili - riflette Magrini - bisogna mettersi assieme, ognuno con la propria individualità, ma con rispetto degli altri».
La partita era troppo grossa, fallire non era consentito.
L’assetto internazionale
E proprio perché non era consentito fallire, il Governo sposò la linea della grande alleanza e delegò la gestione della ricostruzione alla Regione.
«Il Governo si rivelò molto sensibile nei confronti del Friuli anche perché, ma questa è una mia interpretazione, il sisma aveva colpito la parte più arretrata della regione che da Caporetto ai Cosacchi, all’emigrazione, aveva vissuto diversi guai. Una regione confinante con la federazione jugoslava, dove premevano il patto di Varsavia e alcuni fenomeni di autonomismo e separatismo in atto, senza contare che metà esercito, provvidenziale in certi momenti, era presente proprio in Friuli».
Una situazione internazionale delicata alla quale si univano l’incubo del Belice e del Vajont. «In un contesto difficile, le amministrazioni rispondevano ai partiti che avevano il ruolo di tranquillizzare la gente e di portarla su soluzioni concrete».
Magrini percorre quei momenti con estrema lucidità politica, si sofferma sulla partecipazione popolare alle volte molto accesa nelle tendopoli e nelle baraccopoli e ricorda che «il compito dei partiti e degli iscritti tutti era quello di mantenere il clima su posizioni ragionevoli».
Gli uomini dimenticati
Il pensiero di Magrini va ai politici dimenticati. «Si continua a ricordare il lavoro svolto dal commissario per l’emergenze, Giuseppe Zamberletti, che - confessa - io vedeva come fumo negli occhi alla pari di alcune posizioni espresse dalla Chiese e dalle sue organizzazioni, anche qui molto differenziate».
Lo stesso vale per gli intellettuali che sicuramente diedero un contributo, «benissimo, ma ora parliamo di quelli che, in senso metaforico, hanno spostato le pietre non dei faraoni che hanno dato il nome alle piramidi».
A suo avviso, nella partita del terremoto tra gli uomini più rilevanti furono «Adriano Biasutti, esponente Dc di primo piano in regione, mente politica, uomo con una dialettica robusta a cui ero molto legato. Francesco De Carli, un socialista sanguigno con le idee molto chiare e Antonio Moschioni uno degli uomini più importanti del Pci che io seguivo».
Uomini che affidarono a Magrini la presidenza della commissione speciale per le zone terremotate «dividendo praticamente la regione in due: nelle zone terremotate, deboli, gracili, la commissione speciale esaminava e controllava tutto, mentre il resto della regione dipendeva dalla maggioranza di governo».
In quel clima i politici fecero un patto di ferro: «Dobbiamo essere galantuomini e fare il nostro dovere». Lo rivela Magrini stanco «dell’enfasi e della retorica» con cui si continua a ricordare quegli anni.
«Eravamo stati eletti per rappresentare le popolazioni ferite dai lutti, a cui erano cascate le case, le fabbriche e le stalle, il nostro dovere era quello di rappresentarle facendo il nostro mestiere dignitosamente. Non siamo stati degli eroi, per questo non mi piace parlare di modello Friuli, bensì di esperienza Friuli».
Un’esperienza maturata in un confronto acceso che favoriva il controllo popolare. «Una delle cose di cui vado fiero - aggiunge - è che abbiamo dimostrato al popolo italiano, perché i quattrini erano del popolo italiano, che qui nessuno ha fatto il furbo».
Spazio alle competenze
Nessuno ha fatto il furbo perché i politici si fidarono dei tecnici scelti in base alle competenze. «Nei gruppi A e B i tecnici erano indicati dai partiti, se oggi un politico indica l’ingegner Bianchi viene fuori un pandemonio. Nella stessa Segreteria generale straordinaria gli appalti erano gestiti dal direttore Chiavola e dai rappresentanti dei partiti. E gli ingegneri e gli architetti erano orgogliosi di dire “faccio parte di questo o quel partito”».
Erano altri tempi. Basti pensare che quando si trattò di ricostruire il patrimonio zootecnico i politici dissero ai commercianti di bestiame: «Quando battete le aste - lo rivela sempre Magrini - dovete tenere i prezzi bassi. Ci ascoltarono. Abbiamo fatto il nostro dovere per rimettere in piedi il tessuto abitativo, economico e sociale». Determinante il ruolo dei sindaci.
Sistema ripetibile
Quarant’anni dopo diventa difficile pensare che i partiti possano tornare a gestire appalti e a nominare i tecnici. Quello che si può recuperare, però, è la visione ampia dei politici di allora.
«Biasutti - sono sempre le parole di Magrini - con le sue capacità di democristiano un po’ anomalo, affrontava i problemi con un’ottica sempre molto ampia all’inizio. Come tutti quelli di sinistra e del Partito comunista in particolare, partiva dall’analisi della situazione internazionale, Urss, patto di Varsavia e la presenza di Tito, senza dimenticare la storia».
Da queste riflessioni, in assemblee infuocate dove la gente pretendeva la presenza dei politici, nascevano le soluzioni. Oggi come allora, Magrini amplia la visione, rilegge la storia e si chiede: «Nella zona montana, dalla destra alla sinistra del Tagliamento, dove si vive un momento difficilissimo, è possibile, nel rispetto delle singole posizioni, pensare di far rinascere quella grande alleanza politica a supporto delle zone deboli? Direi proprio di sì. Se poi vogliono partecipare anche i prelati gli diamo diritto di parola».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto









