Le mummie morte due volte

VENZONE. Sono rimaste sotto le macerie anche loro, il terremoto che ha squarciato il duomo e ha gravemente leso la maestosità del campanile fino a minacciarne la sopravvivenza, non ha risparmiato neppure loro, le mummie di Venzone, che erano la concreta raffigurazione della morte: attendevano da secoli o da decenni il giorno del Giudizio universale per riprendere la loro carne, ripiegate su sé stesse - o inclinate chi di qua e chi di là per non perdere il segnale, da qualsiasi parte provenisse, per avvertire le altre - stavano attente se si levasse il suono delle trombe dell'Apocalisse del loro paese medioevale e di tanti altri paesi antichi tutt'intorno: la rotonda che era il loro cimitero privato ma aperto al pubblico dei visitatori è crollata, i vetri delle nicchie che li custodivano si sono infranti, ed esse sono cadute nella polvere: le ventuno salme di Venzone, sono morte un'altra volta.
Chi non le conosceva, le mummie di Venzone? Almeno di nome, e almeno qui in Friuli, le conoscevano persino i bambini delle scuole elementari, che sgranavano gli occhi quando il maestro spiegava che la mummificazione delle salme di Venzone era un fenomeno naturale, non aveva niente da spartire con quella degli antichi egiziani, i quali dovevano ricorrere ad autorevoli personaggi, a metà medici a metà sacerdoti, che a loro volta impiegavano gran tempo per preparare i balsami della conservazione prima di porre il corpo del morto nel sarcofago.
Quante volte tutti noi abbiamo sentito ripetere, e abbiamo ripetuto, che le mummie di Venzone erano rimaste così - per via di un fungo, di una pianta parassitaria antibiotica che vegeta nelle tombe del duomo e ha la proprietà di essiccare i tessuti del corpo umano senza più vita: basta un anno, e la pelle si trasforma in una specie di cartapecora.
E a tutti non è piaciuto credere che fosse storia vera e non soltanto tradizione il desiderio di Napoleone di essere sepolto a Venzone per divenire mummia anche lui: visitò la cittadella nel 1807 e allora non poteva sapere che sarebbe stato irrimediabilmente sconfitto a Waterloo e che sarebbe morto in esilio nell'isola di Sant'Elena: perciò dovette sedurlo l'idea di garantirsi una parvenza di immortalità anche fisica attraverso la mummificazione.
Certo è il fatto che nessuno dei tanti e tanti che dal Friuli e da ogni altra regione d'Italia e dall'estero salivano a Venzone, o vi scendevano, per visitare la cittadella chiusa nella doppia cinta delle sue mura, tralasciò mai di recarsi nella "rotonda", che era poi (possiamo dire che lo sia ancora, se di essa sono rimasti pochi brandelli di muro, alti sì e no un paio di metri?) il battistero del duomo.
Pochi sapevano di percorrere lo stesso cammino compiuto da due imperatori - o meglio tre, se mettiamo nel conto anche Napoleone -: Francesco I d'Austria nel 1819, e diciannove anni più tardi Ferdinando I suo successore; e forse nessuno ha mai pensato che forse Venzone aveva un suo "prato dei miracoli", certamente meno famoso e più modesto di quello di Pisa, ma in tutto simile ad esso per gli elementi compositivi: il duomo, la torre (qui sostituita dal campanile) e il battistero.
Così come forse nessuno ha mai pensato che le mummie di Venzone suggerivano un'idea familiare della morte al pari di quella che nasce dalla contemplazione di alcune scene del "Giudizio universale" dipinto da Luca Signorelli nell'abside del duomo di Orvieto.
Perché al di là della curiosità che ne faceva addirittura un richiamo turistico, il segreto dell'interesse popolare per le mummie di Venzone era questo: la mancanza del macabro, l'assenza dell'orrore della morte. Sapere o non dei trasferimenti delle salme, conoscere o ignorare le vicende delle non poche estrazioni e delle diverse esposizioni che loro furono date, alla gente che sopra tutto la domenica andava a visitarle importava che non ne rimaneva sconvolta, o turbata, e tantomeno impressionata: era come recarsi a un doveroso appuntamento.
Soltanto a qualcuno poteva interessare che si trattasse di tre sacerdoti morti in epoche diverse, di tre esponenti della nobiltà friulana di due coppie di sorelle, d'una coppia di sposi, di uomini e donne di casato ignoto: quanti desideravano informazioni precise andavano a leggersele su una sorta di dépliant in vendita nell'interno del battistero (che poi era per tutti, più semplicemente, "la Rotonda") o nelle pagine della minuziosa guida storico-artistica di Venzone recentemente redatta da Guido Clonfero.
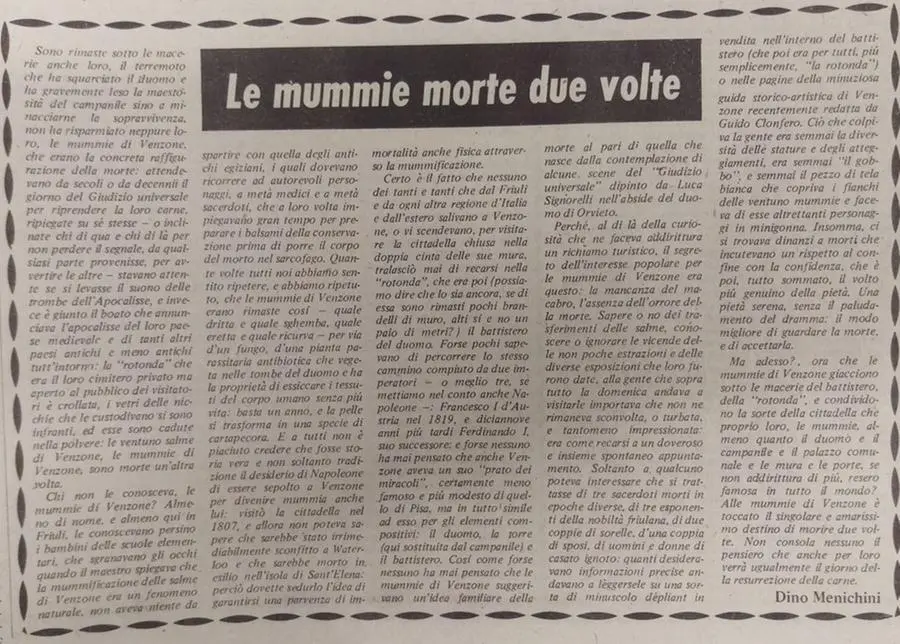
Ciò che colpiva la gente era semmai la diversità della statura e degli atteggiamenti, era semmai "il gobbo", e semmaiil pezzo di tela bianca che copriva i fianchi delle ventuno mummie e faceva di esse altrettanti personaggi in minigonna. Insomma ci si trova d'innanzi a morti che incutevano un rispetto al confine con la confidenza che poi, tutto sommato, il volto più genuino della pietà. Un pietà serena, senza il paludamento del dramma: il modo migliore di guardare la morte e accettarla.
Ma adesso? Ora che le mummie di Venzone giacciono sotto le macerie del battistero, della "Rotonda", e condividono la sorte della cittadella che proprio loro, le mummie, almeno quanto il duomo e il campanile e il palazzo comunale e le mura e le porte, se non addirittura di più, resero famosa in tutto il mondo?
Alle mummie di Venzone è toccato il singolare e amarissimo destino di morire due volte. Non consola nessuno il pensiero che anche per loro verrà ugualmente il giorno della resurrezione della carne.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto










