Albert Einstein, tra genio e scienza pop
Domenica 23 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ultimo appuntamento con le Lezioni di Scienze, ciclo di tre incontri dedicati ai Grandi Maestri che, da questa stagione, ha affiancato le Lezioni di Storia
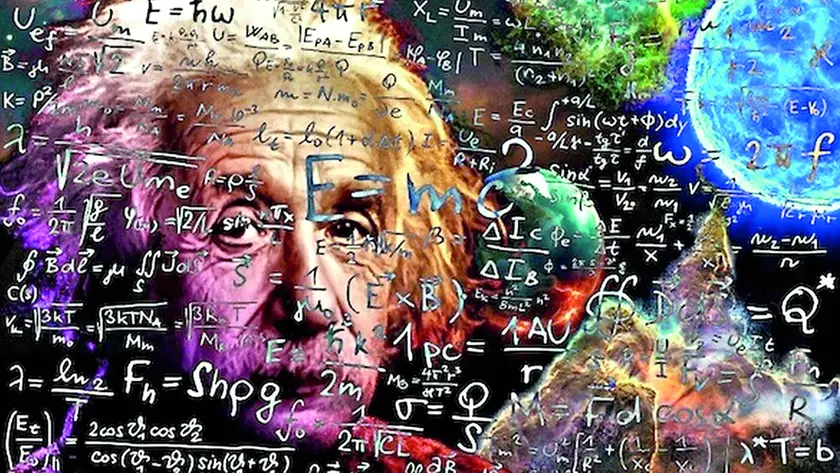
Ma chi era davvero Albert Einstein? Il genio che conosciamo tutti con i capelli spettinati che mostra la lingua diventando immediatamente lo scienziato più pop della storia o anche altro? E cosa ci offre lo studio della scienza attraverso i suoi maestri? Senz’altro che tempo, competenza e studio sono necessari e il dubbio e l’errore sono fondamentali per il progresso del sapere in ogni settore.
Domenica 23 marzo (inizio come di consueto alle 11) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ultimo appuntamento con le Lezioni di Scienze, ciclo di tre incontri dedicati ai Grandi Maestri che, da questa Stagione, ha affiancato le amatissime Lezioni di Storia.
Ognuno dei tre appuntamenti in programma, una collaborazione Editori Laterza e Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, realizzata con il sostegno di Confindustria Udine.
Media partner Messaggero Veneto, è stato pensato per ricostruire un capitolo avvincente dell’evoluzione del nostro sapere e proprio per riflettere sull’origine di conoscenze e pratiche che sono poi entrate nella nostra quotidianità.
Protagonista dell’ultimo incontro, il professor Piero Martin, ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Padova, attualmente distaccato presso il Centro Interdisciplinare “B. Segre” dell’Accademia Nazionale dei Lincei e visiting professor presso la Columbia University di New York. Studioso della fusione quale sorgente di energia, Fellow dell’American Physical Society, è stato responsabile scientifico di grandi progetti internazionali e oggi coordina le attività di fisica di DTT, il nuovo grande esperimento di fusione italiano. Con Laterza ha pubblicato “Le 7 misure del mondo”, (tradotto in otto lingue e finalista al Premio Galileo 2022), “Storie di errori memorabili” ed è in prossima uscita “Questo è quanto”, viaggio nella fisica quantistica sempre per Laterza.
Professor Martin, se recuperiamo dai ricordi scolastici, Albert Einstein è associato alla scoperta della bomba atomica, e alla formula della Relatività E=mc^2. La sua lezione ci aiuterà a capire qualcosa di più del Genio di Ulm, Premio Nobel per la Fisica?
«Einstein ha avuto certamente un ruolo nell’invenzione della bomba atomica ma certamente non cruciale. Il suo contributo alla scienza è stato per ben altro. Ad esempio, per le due grandi rivoluzioni della cultura del XX secolo e della scienza, ovvero la meccanica quantistica e la relatività, due teorie che ci hanno permesso di scrutare l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande. La teoria della relatività è sua. Alla meccanica quantistica ha dato un contributo importante. Anzi è il tema per cui lui vince il Premio Nobel. Nella mia presentazione cercherò di presentare gli aspetti meno noti di Einstein che è stato un genio a tutto tondo. L’altro aspetto che approfondirò è il tema dell’umanità e delle contraddizioni».
Ad esempio?
«Con la sua lettera al presidente Roosevelt fece partire il programma Manhattan nel 1939 ma nel 1947, nell’intervista rilasciata a Newsweek disse: “se avessi saputo che i nazisti si sarebbero arresi, alla bomba atomica non ci avrei mai lavorato”. Sempre a proposito di contraddizioni è uno dei grandi padri della fisica quantistica che introduce il principio di indeterminazione ma ad un certo punto si spaventa. È nota la sua frase: “Dio non gioca a dadi”. Einstein era impegnato fortemente per la pace e contro il razzismo. Testimoniò con la sua stessa vita l’attenzione ai temi della lotta al razzismo. Invitò a casa sua la famosa cantante d’opera Marian Anderson che era stata rifiutata da un albergo di Princeton perché nera. Aveva una forte attenzione alle tematiche sociali e politiche. Questo per far capire che la scienza è fatta da esseri umani».
Quanto è importante spiegare la fisica in un modo comprensibile a chi è interessato?
«Direi fondamentale, quasi un dovere civico. Per noi che facciamo scienza è importante il confronto con confronto con le colleghe e i colleghi ma oggi c’è un bisogno diffuso di conoscenza scientifica. La scienza entra in moltissimi aspetti della vita. Faccio un esempio io ho studiato al liceo classico e la maggior parte dei miei compagni di classe si era iscritto al liceo classico perché non voleva saperne della matematica e ancora oggi in tanti dicono “io la matematica e la fisica non le capirò mai”. In realtà è importante trovare dei bravi maestri. A livello di comprensione di base, la scienza è accessibile a tutti. Poi ci saranno certo i professionisti che arriveranno a un certo livello, ma comunicare gli elementi fondamentali in modo accessibile è responsabilità di chi, come me, la racconta».
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








