Arriva l’abbecedario dei proverbi friulani per imparare anche divertendosi
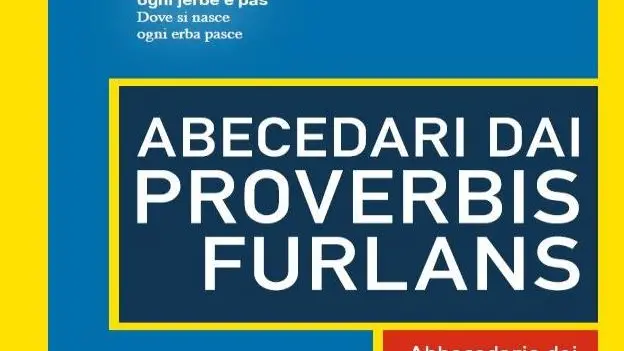
«Ogni mês si fâs la lune, ogni dì si impare une». Imparare dai proverbi è più divertente. Se ne trovano «a sbreghebalon» (in gran quantità) insieme ai modi di dire, in Abecedari dai proverbis furlans (Editoriale Programma) di Mario Martinis, in vendita da venerdì 19 in abbinamento al Messaggero Veneto e a Il Piccolo, «par un blanc e un neri» (ossia “a un prezzo bassissimo”): euro 7,90.
«Si tratta – spiega l’autore – di un libro che viene da lontano, ma destinato al friulano di oggi e di domani, che voglia essere cosciente protagonista, nutrito dal “sale” degli antenati. Questa raccolta può aprire un orizzonte più vasto sul rapporto necessario fra identità, localismo e universalità». Proverbi friulani, nati in un contesto contadino del passato, possono specchiarsi in altre culture o lingue, dialogare con esse, parlare all’uomo e alla donna di oggi attraverso una letteratura sapienziale che supera i confini, presente in tradizioni occidentali e orientali, pagane e cristiane.
Mario Martinis, giornalista, ricercatore di storia ed etnoantropologia, cultore della civiltà friulana, raccoglie attraverso un criterio tematico, in una cinquantina di voci, oltre 1.500 proverbi e modi di dire, scelti tra i più diffusi e incisivi. «Una raccolta presentata (ed è la prima volta) nella koiné friulana, nella grafia ufficiale normalizzata, per renderla più adatta a penetrare il territorio e a diventare materia scientifica», anche se varianti locali sono state mantenute per non perdere rime caratteristiche.
Precetti essenziali, trasversali, universali, efficaci, brevi, scaturiti da saggezza ed esperienza collettive, a tramandare un avvertimento, una credenza, una norma di buon senso, non calata dall’alto di una cattedra, ma generata da umili, ritmate e giocose sonorità: assonanze, allitterazioni, rime che rendono spassoso e memorizzabile il pensiero.
Il repertorio friulano è innanzi tutto contadino: parla di stagioni, luna, usanze, ricorrenze, animali, meteorologia, coltivazioni. «Lis plui bielis lagrimis a son chês de vît» (le più belle lacrime sono quelle della vite). Quanto al vino, «la ultime tace e je chê che incjoche» (l’ultimo bicchiere è quello che ubriaca).
Un repertorio che diventa ironico, specie sul matrimonio: «A maridâsi si sta ben un mês, a copâ il purcit un an» (a sposarsi si sta bene un mese, ad ammazzare il maiale un anno). Già, perché «se al jere un bon sacrament, se lu tignivin i predis» (se era un buon sacramento, se lo tenevano i preti).
Vizi e virtù sono temi prediletti. Prima o poi «la bausie come il vueli e ven parsore» (la bugia come l’olio emerge), perché «la veretât no à cuvierte» (la verità non ha coperta). «La supierbie e va a cjaval ma e torne a pît» (la superbia va a cavallo ma torna a piedi). «A fâ il pas plui lunc de gjambe si romp il cavalot» (a fare il passo più lungo della gamba si rompe il cavallo dei pantaloni). Invece «amôr al fâs amôr» (amore fa amore). Il popolo friulano è generoso: «Là che a stan sîs a stan ancje siet» (dove stanno sei stanno anche sette). Ma guai a dimenticare la gratitudine: «No sta taiâ l’arbul che ti à parât de ploie» (non tagliare l’albero che ti ha riparato dalla pioggia).
La vita è fatta di luci e ombre: «Ancje il soreli al à lis sôs maglis» (anche il sole ha le sue macchie). E «ancje il diaul al jere un agnul tal imprin» (anche il diavolo era un angelo all’origine). Bisogna trovare il bene anche nel male: «Nol è mai un mâl che nol sei il so ben». Tutto ha un senso: «Nol è tapon che nol vadi ben su cualchi cite» (non c’è coperchio che non vada bene su qualche pentola).
Il segreto è accontentarsi: «Alc al è alc e nuie al è nuie» (qualcosa è qualcosa e niente è niente). Bisogna saper aspettare: «Nol è miluç tant dûr che cul timp nol deventi madûr» (non c’è mela tanto dura che col tempo non maturi).
Ironizzare sulla morte è esorcizzarla: «Al è lât a viodi il lidric cul poc» (è andato a vedere il radicchio dalla radice) oppure «Al à dismenteât di tirâ flât» (si è dimenticato di respirare).
Su tutto regna il lavoro e la condanna dei fannulloni: «Sant Fos, Sant Ves e Sant Sarès a son trê sants che no judin» (San Fosse, San Avessi e San Sarebbe sono tre santi che non aiutano).
Il libro si riallaccia al lavoro di Valentino Ostermann e di Lea D’Orlandi, segnando un’evoluzione nella storia delle raccolte di proverbi friulani. La più antica è contenuta in un manoscritto cinquecentesco con locuzioni in più lingue: 26 friulane, stampate da Vincenzo Joppi nel 1878, a cui è dedicata la Biblioteca Civica di Udine, custode del manoscritto.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto







