Da Graham Greene a le Carré i nostri agenti segreti nella Storia
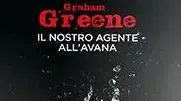
RAFFAELLA SILIPO
«Credo che l’80 per cento della storia sia segreta. Che gli uomini dei servizi segreti abbiano davvero un’influenza terribile sul corso delle azioni umane» dice Daniel Silva, uno dei più interessanti autori contemporanei di spy stories. E in effetti si impara anche la Storia, oltre ad appassionarsi alle storie, leggendo i grandi romanzi della letteratura spionistica, in vendita con il Messaggero Veneto a 7 euro e 90 centesimi piú il prezzo del quotidiano.
Testi per anni ingiustamente considerati minori, ma che non hanno nulla da invidiare alla letteratura vera, anzi: offrono un viaggio adrenalinico nelle trame, nei personaggi, nei luoghi più o meno esotici, e contemporaneamente una rilettura dei grandi eventi del secolo passato - le guerre mondiali, la Guerra Fredda, la lotta al terrorismo islamico - da un’angolatura diversa. Segreta, appunto. Ma non per questo meno reale. Anche perché molti autori presenti nella collana - appartenenti a diverse generazioni ma legati dal filo rosso di un unico destino - sono stati davvero agenti, sovente al Servizio di Sua Maestà (data la prevalenza dei britannici tra i maestri del genere). E non a caso i loro eroi sono spesso antieroi, uomini in grigio piuttosto che principi degli inganni. A cominciare dall’Ashenden di William Somerset Maugham (classe 1874), di stanza nella Svizzera del 1919, dove cerca di districarsi tra lo spettro del comunismo e i fantasmi degli imperi passati, facendo un lavoro «indubbiamente necessario e tuttavia non poteva dirsi altro che monotono».
Discorso analogo per Graham Greene (classe 1904), agente durante la II Guerra mondiale e uno dei maggiori romanzieri inglesi del 900. È proprio suo il capolavoro che apre il ciclo, quel Nostro agente all’Avana diventato proverbiale per l’ironia con cui descrive un uomo qualunque che si arrabatta tra personaggi e scelte di dubbia moralità. Hanno invece un loro tranquillo eroismo le spie malinconiche di John Le Carré (classe 1931), che nella Spia che venne dal freddo e soprattutto nella serie di George Smiley, riversa tutto il suo disincanto di agente durante la Guerra Fredda, «bruciato» dal traditore Kim Philby. Piglio più sanguigno per il collega e quasi coetaneo Frederick Forsyth (classe 1938), che nel Giorno dello sciacallo descrive un complotto per assassinare il presidente francese De Gaulle.
Dell’elenco fanno parte anche Ken Follett, maestro di romanzi storici e di tensione, come ben testimonia La Cruna dell’ago, dove l’Ago è un’efferata spia nazista; Robert Harris, che in Enigma racconta la caccia dell’intelligence britannica ai codici segreti tedeschi nella II Guerra mondiale; Robert Ludlum, creatore di Jason Bourne, sorta di 007 statunitense consacrato da Matt Damon al cinema. E il già citato Silva, ex reporter di guerra della Cnn, che racconta gli scenari mediorientali del nuovo terrorismo dal punto di vista della spia-restauratore Gabriel Allon.
Senza dimenticare l’illustre progenitore Joseph Conrad. È anche grazie al suo Agente segreto che il mestiere di spia diventa, appunto, un mestiere. Dove sono richieste intelligenza e coraggio, ma ben poche illusioni sul genere umano. D’altronde, diceva lui, «la vita non sopporta che ci si guardi troppo dentro». —
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








