Dai fiumi alle rogge, la storia del Friuli raccontata attraverso i suoi corsi d’acqua
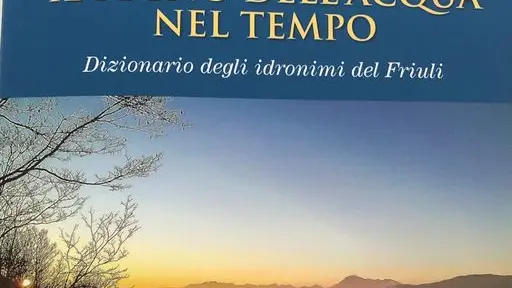
gianfranco ellero
Abitate lungo un’acqua di Udine e non sapete perché la chiamano “Roggia di Palma”? Andate per una passeggiata a Cergneu e vorreste sapere perché il torrentello si chiama Lagna? Giustamente ridete per l’interpretazione popolare di Cormôr (al cor e al môr) o di Lèmene (acqua calma che corre lemme, lemme) e vi interessa l'arcana verità nascosta in quei nomi?
Potete trovare queste a molte altre risposte, documentate da fonti storiche, nel volume “Il segno dell'acqua nel tempo”, di Barbara Cinausero Hofer ed Ermanno Dentesano per le edizioni Ribis di Basaldella.
In questo grosso tomo fresco di stampa ogni acqua del Friuli risulta catalogata con una scheda contenente i nomi che la distinguono (per esempio Tiliment, Timent, Taiament, in cartografia Fiume Tagliamento), la descrizione topografica e fisica (la Lagna “scende dai monti Zisilin, Namlen, Nagrad e San Giacomo e si porta a OSO passando poco a sud del capoluogo: subito dopo si immette da sinistra nel Cornappo ...”), i documenti che la nominano in tempi diversi e l’interpretazione del nome dell’acqua (tecnicamente dell’idronimo) alla luce delle scienze linguistiche.
Ed è qui che si fanno le scoperte più interessanti. Il Cormor non corre e muore: fu così chiamato, secondo i due studiosi, perché ristagnava e si impaludava tra Buja e Tricesimo; la Lagna non è “una lagna”, bensì semplicemente un fiume secondo una forma latina; e la parola Sile sta per “sprizzante” o “zampillante”, significati che mettono radici in una lingua lontana nel tempo. Ci sono poi “segni” d'acque con lo stesso nome ma di differente età. Il Ledra, che da Artegna, passando a nord di Buja, si getta nel Tagliamento all’altezza di Cimano, ha un nome antichissimo, che affonda le radici glottologiche in lingue indoeuropee con il probabile significato di “acqua” come nel greco “idros” (per semplicità traslitterato nell'alfabeto latino). Ma quel fiume dà origine al Canale del Ledra, nominato soltanto in documenti recenti (Ottocento): è la stessa acqua che scorre dapprima in un letto naturale e poi in un canale artificiale, e cambia genere passando dall'italiano al friulano: il Ledra e la Ledre. Naturalmente le acque più importanti sono citate in documenti molto antichi: il Tagliamento trova posto nella “Naturalis Historia” di Plinio, nella “Geografia” di Tolomeo, e con il nome di “Tiliabinte” lo vediamo addirittura rappresentato nella “Tabula Peutingeriana”, intinerario romano del III secolo.
Anche la Livenza, il Torre e il Natisone trovano posto nell’opera di Plinio e in altre fonti antiche. L’Isonzo divenne addirittura un dio dell’Olimpo aquileiese con il nome di Aesontius, e in friulano viene chiamato Lisunz ad Aquileia, Lusins a Fiumicello, Isuns a Ruda … Sóča in sloveno.
Scorrendo l’interessantissimo volume di Cinausero e Dentesano, un’autentica miniera storica e linguistica, si scopre che le acque del Friuli mutarono non soltanto il nome nel tempo, ma anche talvolta il loro corso: si pensi ai due Tagliamenti descritti da Plinio ad esempio, e sorge spontanea una riflessione: la definizione del Friuli di Giovanni Boccaccio, “paese quantunque freddo lieto di belle montagne, di più fiumi e chiare fontane” dovrebbe essere integrata con le parole “e molti canali artificiali”.
Il titolo del volume, infine, si specchia nell’immagine creata nel secolo scorso dal Premio Nobel Eyvind Johnson, il quale interpreta il Friuli fisico come l’impronta della zampa di un orso, che posò il palmo sulla pianura e con gli unghioni scavò le valli alpine: i segni delle acque, appunto, che formarono la permeabile pianura triturando montagne. —
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








