Il Friuli di Sgorlon tra mito e realtà: dalla natìa Cassacco agli angoli di Udine
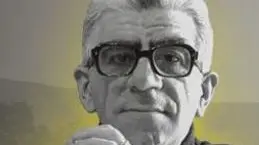
“Alla ricerca del Friuli mitico” potrebbe essere il titolo, preso a prestito da Proust, per delineare un itinerario sgorloniano. Il Friuli di Carlo Sgorlon c’è, non c’è, si dice. “C’è”, negli aspetti legati alla realtà autobiografica e dei luoghi storici rievocati epicamente. “Non c’è”, nella misura in cui quella realtà evapora in mito, negli archetipi di Jung o in luoghi inventati, universali, senza tempo o sempre stati. È anche il Friuli popolare del “si dice”, del tramandare: dicerie, superstizioni, credenze, leggende, magie di una civiltà contadina, arcaica, sacra.
Eppure, famoso è il lamento dello scrittore, nella sua autobiografia, ma anche nelle confidenze alla redazione del Messaggero Veneto con cui collaborava: si sentiva figlio del Friuli, ma sapeva di non essere figlio unico. Da qui, il ritenersi incompreso nonostante la scia di premi e riconoscimenti.
Viaggiare nel suo Friuli significa andare in cerca di luoghi mitizzati o dai nomi inventati. Punto di partenza un paese reale, Cassacco. Simbolico e autobiografico è l’edificio in cui venne alla luce, nel 1930, grazie alla nonna levatrice: le scuole elementari che, seppur non frequentate, costituiranno un luogo di predestinazione di un mestiere di famiglia. Maestri furono il nonno, che in esse viveva, la mamma e la moglie. E professore fu Sgorlon. L’itinerario non può che partire da quell’edificio, oggi biblioteca, in cui consultare i libri dello scrittore che, a questo punto, ci consiglierebbe di continuare, insieme a lui, il viaggio in bicicletta, attraversando le campagne nei dintorni di Cassacco, distese o lievemente collinari, dietro le quali si cela la maggior parte di quei nomi creativi del suo Friuli mitico.
Ecco allora le frazioni di Martinazzo, paese del nonno che lo ha istruito, e di Raspano, dove Sgorlon abitava saltuariamente e dove oggi è sepolto, accanto alla chiesa di San Marco, eretta sul sito del precedente edificio tardo medioevale, attorno al quale si sviluppò l’antico abitato contadino, nutrito di credenze e storie.
A Cassacco, paese sovrastato dal castello (risalente al Duecento e collegato, secondo una leggenda, al castello di Tricesimo attraverso un sotterraneo) e dal campanile (copia della torre campanaria della cattedrale di Lucca) è ambientato “Prime di sere” e anche il primissimo racconto “La casa di Coròss”, storia di un pollivendolo.
Il viaggio, attraversando Tricesimo e Reana, paesi legati ai nonni e al vissuto, prosegue verso Udine, indugiando ancora su una scuola, l’Istituto Zanon, in cui a lungo insegnò e vicino al quale abitò, oltre i resti della cinta muraria di Porta Villalta, seguendo il corso della roggia, all’angolo dell’amato vicolo Sutti.
È l’anima popolare della città, dei borghi in cui visse. Per tre anni dimorò, con moglie e suocera, anche in via Giovanni da Udine, raggiungibile attraversando via Mantica e via Mazzini, dove resiste, dal Trecento, la più antica casa della città. Tra i luoghi vissuti dallo scrittore c’è anche l’ex collegio Toppo Wassermann, oggi sede dell’Università.
Poco più in là, in via Gemona, la casa di Giovanni da Udine, che fa angolo con la strada dedicata al pittore-architetto, collaboratore di Raffaello. Giardin Grande fu spazio dell’adolescenza di Sgorlon, alunno del Liceo Stellini che si affaccia sulla piazza, mentre la Biblioteca Joppi di Palazzo Bartolini fu luogo di studi e ricerche. In città è ambientata “La contrada” e via Giovanni da Udine ispirò le vecchie case cinquecentesche veneziane de “La poltrona”.
Altrove potrebbe proseguire il viaggio, in alcuni luoghi storici rievocati dalle opere: il Vajont de “L’ultima valle”, Porzûs de “La malga di Sîr”, la Carnia cosacca de “L’armata dei fiumi perduti”. Tanti, in quest’ultima, i motivi ed episodi tratti da Bruna Sibille-Sizia, trasferiti dal Torre al Tagliamento.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








