Il manoscritto Voynich e i suoi antichi segreti: una storia iniziata in Carnia
Esce il volume “Beinecke 408” di Eleonora Matarrese. L’opera contiene nuove scoperte sul codice del XV secolo
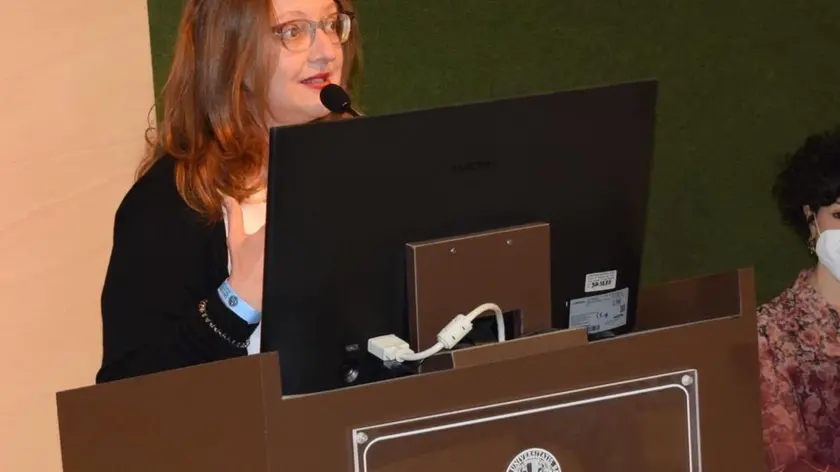
Per secoli ha custodito i suoi segreti malgrado anche i crittografi di Hitler, assieme a tanti altri studiosi, avessero provato a decifrarlo.
Numerose le ipotesi fiorite sul manoscritto Voynich, opera del XV secolo che deve il proprio nome a Wilfrid Voynich, mercante di libri rari polacco-lituano, il quale lo acquistò dal Collegio Romano dei Gesuiti di Villa Mondragone e Frascati, nel 1912.
La studiosa pugliese Eleonora Matarrese lo ha studiato per un quindicennio, fino a individuarne la lingua, alcune importanti indicazioni e il luogo d’origine che porta nelle Terte alte del Friuli.
Laureata in Lingue e letterature straniere e specializzata in Filologia germanica, Matarrese insegna Etnobotanica e Fitoalimurgia all’università degli studi di Bari.
«Fu una mia corsista a segnalarmi quel manoscritto tanti anni fa – racconta –, mi colpì principalmente l’erbario». Il manoscritto è infatti un codice illustrato composto da quattro trattati: un erbario, una calendario, un manuale sui benefici termali, un trattato agronomico sulle piante spontanee, corredato da un ricettario.
Il testo fu donato alla biblioteca dell’Universitaà di Yale, da qui il nome con cui è archiviato: Beinecke 408.
Si è ritenuto che fosse un almanacco di medicina, dato il contenuto e le illustrazioni. Alcuni studiosi hanno sostenuto che si trattasse di un falso cinquecentesco. A ben altre conclusioni è giunta Matarrese, che ha raccolto le sue scoperte nel libro “Beinecke 408. Il manoscritto Voynich” disponibile su Amazon anche in Ebook.
«Il cosiddetto “calendario” non è giuliano né gregoriano – spiega la studiosa – si tratta di un calendario “agricolo” precedente, legato all’osservazione della Natura. Il folio 57v presenta stilemi tipici di manoscritti germanici di epoca medievale, con probabili influssi slavi. Le piante cui si riferisce esistono in Carnia.
La lingua utilizzata èun dialetto medio tedesco di area carnica, un unicum che riporta à Timau/Tschilbong e Tolmezzo, ma sono almeno cinque le mani che intervennero su quel testo. Probabilmente – aggiunge – erano Cramàrs. La traslitterazione completa di tutto il manoscritto, a cui sto lavorando, porrebbe nuovi scenari sia nell’ambito della filologia germanica, sia nella storia dei popoli germanici e slavi pre-cristiani, che della storia della botanica, oltre che della storia dei rapporti tra le popolazioni di confine e le isole linguistiche da preservare».
Nel corso della ricerca Matarrese ha visionato incunaboli alla Biblioteca Universitaria di Pavia del Ministero della Cultura, di cui uno è stato pubblicato a Magonza ed è un erbario in latino: lo stesso erbario si trova, ma in lingua tedesca dell’epoca di stampa (XV secolo), al Museo di Arti Popolari Gortani di Tolmezzo, e come l’incunabolo di Pavia presenta glosse con caratteri simili a quelli del Beinecke 408. Inoltre, all’ingresso del Museo di Tolmezzo vi è parte di un affresco incorniciato che illustra la capitale della Carnia, nel XV secolo con il castello e le mura circondata da un fiume e in primo piano quattro figure femminili.
Quella centrale, con un velo e una corona, è nuda e vicino il corso d’acqua e con un globo in mano: ricorda sia una delle figure del folio 57v che una di quelle del cosiddetto “trattato delle acque”. «Vi è sicuramente un legame dal punto di vista iconografico che mi riservo di documentare e pubblicare nei prossimi volumi che saranno pubblicati nell’arco del 2024» annuncia Matarrese.
«Ancora una volta ci troviamo di fronte a una preziosa testimonianza della ricchezza della storia della Carnia custodita al Museo delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, che continuerà a impegnarsi a supportare gli studi dei ricercatori aprendo le porte alla documentazione conservata, non solo al museo, ma anche a casa Gortani – commenta la presidente della Fondazione Museo Carnico, Aurelia Bubisutti –. Le connessioni trovate da Eleonora Matarrese ci confermano, sempre di più, l’importanza dell’erbario “Gart der Gesundheit” già studiato da Domenico Molfetta.
Conservato al Museo, posso anticipare che a breve la sua bacheca sarà posizionata nella sala dedicata ai Cramàrs insieme a un tablet che permetterà a ricercatori e visitatori di consultare liberamente la copia digitale di questo erbario, che ci è stato donato dall’Archivio di Stato di Trieste».
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto







