Montanelli “contro corrente” come il carattere degli italiani
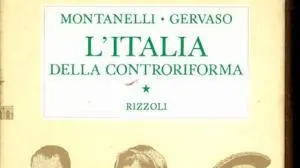
Esce con un quotidiano nazionale l’ennesima ristampa dei ventidue volumi della “Storia d’Italia” di Indro Montanelli, e va a ruba. È possibile parlare male contemporaneamente di uno dei più grandi giornalisti d’Italia e dell’opera storica che ha venduto di più nell’ultimo secolo? Ci proviamo.
Prima però, un po’ di storia della “Storia” di Montanelli, che nasce un po’ per caso e un po’ controvoglia. Dino Buzzatti spinge l’amico Indro a scrivere una “Storia di Roma” che esce nel 1954 a puntate sulla Domenica del Corriere. Viene quindi proposta in volume ad Arnaldo Mondadori, che la rifiuta. Il libro esce allora da Longanesi ed è un grande successo, tanto da spingere Montanelli a proseguire con una “Storia dei greci”. Anche in questo caso grandi vendite ma anche molte critiche, in un Paese in cui la cultura classica era ancora diffusa e le “volgarizzazioni”, così egli stesso le definiva, appaiono superficiali.
Prende corpo l’idea di mettere in cantiere una storia d’Italia dalla caduta dell’Impero romano al Novecento. Ciò che spinge Montanelli è la convinzione che gli italiani ignorassero il loro passato e che, siccome gli storici professionisti non sapevano parlare alla gente comune, toccasse ai giornalisti colmare il vuoto.
Nel 1965 cominciò così a uscire il primo di sei volumi della “Storia d’Italia”, dedicati all’età medievale e moderna, scritti assieme a un altro giornalista del Corrierone, il giovane Roberto Gervaso; poi ci furono i cinque volumi redatti dal solo Montanelli, e quindi gli undici dedicati al periodo tra Mussolini e Prodi, scritti assieme a Mario Cervi, suo compagno nell’avventura de Il Giornale. Secondo Wikipedia l’opera ha venduto in cinquant’anni venti milioni di copie: entra, come si suol dire, nelle case di tutti gli italiani. Si fa leggere per la sua prosa ariosa, mai sciatta, per la terminologia appropriata, ma non specialistica, per la capacità di caratterizzare psicologicamente i personaggi storici, avvicinandoli al grande pubblico. Una narrazione che rifugge, come tutto il giornalismo montanelliano, dalla retorica; illuminata da ritratti come lampi (Galeazzo Ciano: “un bel ragazzo un po’ del genere tango”) e da frequenti anacronismi che inorridiscono studiosi, insegnanti e intellettuali “costretti” a leggerlo, magari di nascosto.
Gli italiani ritrovano nella Storia le stesse rassicuranti periodizzazioni che hanno studiato sui manuali scolastici del Regno o su quelli, appena ripuliti, della Repubblica. Gli stessi medaglioni di personaggi illustri, la medesima filosofia basica secondo cui la storia la fanno gli uomini, non le ideologie, le economie o le classi. La stessa condanna moralistica degli italiani “Franza o Spagna purché se magna”, con una strizzatina d’occhio al genio italico e alla sua capacità di salvarsi sempre, soprattutto all’ultimo momento. Insomma, una narrazione che non richiede faticosi prerequisiti culturali e che ricorda, negli anni del boom economico, i fasti, e soprattutto le miserie, lasciati alle spalle.
La Storia piace anche per la sua estraneità rispetto alle Chiese/scuole del dopoguerra: quella liberal-marxista che domina gli ambienti culturali e accademici, e per la quale Montanelli aveva un rifiuto quasi fisico; e quella clerical-papale, che vede nella Chiesa il principio ordinatore della storia italiana. Montanelli, empirista filo-anglosassone, “anarchico di destra” (Galli Della Loggia), non vi contrappone alcuna spiegazione storica d’insieme, se non quella del rammarico per la mancata esperienza protestante e di una generica, totale “originalità” del percorso storico italiano, un criterio naturalmente adottabile per qualsiasi Paese in qualsiasi epoca. Se per Benedetto Croce il carattere di un popolo è «la sua storia, tutta la sua storia, nient’altro che la sua storia», per Indro Montanelli, la storia d’Italia consiste più semplicemente nel carattere degli Italiani, nient’altro che questo.
La corporazione degli storici, che dagli anni Settanta si chiude nella spirale dello specialismo, concede a Montanelli il tributo snobistico dell’indifferenza. Dell’evoluzione storiografica novecentesca Montanelli ignora pressoché tutto: la storiografia economico-sociale, il rifiuto della storia fatta solo di uomini politici e guerre, l’attenzione per la storia dal basso, la storia quantitativa, gli intrecci con l’antropologia, la sociologia, la storia culturale. Le generalizzazioni non si contano, e nemmeno gli svarioni, d’altra parte buona parte delle fonti su cui si basa la Storia erano già superate negli anni Sessanta.
Oggi, nell’età della “public history”, della Grande storia alla televisione e delle serie storiche sulle pay-tv, la piccola, vecchia storia di Montanelli, fatta di aneddoti, luoghi comuni e buona prosa italiana d’un tempo, spopola ancora. Da qualche parte, il giornalista di Fucecchio se la ride.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








