«Noi ermetici, incomprensibili al fascismo»
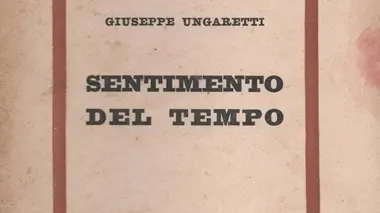
Ottant’anni ci separano dalla nascita a Firenze dell’ermetismo sulle suggestioni certo di “Sentimento del tempo” del 1933 di Ungaretti e di “Ossi di seppia” del 1925 di Montale – anche se lui prenderà chiare le distanze da loro -, ma soprattutto con l’autonomo manifesto “Letteratura come vita” di Carlo Bo, «nostra coscienza di uomini, eterno scandaglio, illuminazioni, sentimento metafisico del Tempo…».
Non ho ancora indicato la data, perché vorrei che il lettore facesse attenzione a questa strana concomitanza: agosto 1938 le leggi razziali di Mussolini, settembre 1938 su Il Frontespizio il manifesto. Solo da questo si comprende che l’intenzione degli ermetici non era solo quella di rinnovare la poesia italiana sulla scorta dei grandi modelli europei, Mallarmé e Rimbaud, con quel che ne consegue di linguaggio analogico, simbolico, oscuro, ma di testimonianza – non azione – politica di totale dissenso dal regime fascista. Il gruppo dei poeti fiorentini - Gatto, Luzi, Sinisgalli… e, nei primi tempi Parronchi, che si riunivano, ognuno con la sua personalità e il suo stile, alle Giubbe Rosse, non costituivano un vero e proprio movimento, ma erano un gruppo di sodali che rifiutando il fascismo condividevano il culto della parola, l’interiorità, tanto è vero che ben presto il gruppo si dissolse, in quanto lo scontro con la realtà della guerra portò diversi di loro a intraprendere percorsi poetici – anche realistici e prosastici – diversi; un po’ la parabola di Quasimodo da “Ognuno sta solo sul cuor della terra” a “E come potevamo noi cantare”. Tra questi anche Alessandro Parronchi, che si ritrasse sulla tematica vita e morte e sul tema della solitudine esistenziale, con un linguaggio, come ha scritto Pasolini «di tono basso, ma visibilmente elaborato, discorsivo, ma non facile, limpido, ma non ovvio». Può comunque essere considerato l’ultimo degli ermetici.
Io ebbi la fortuna di incontrarlo al palazzo Fiorentino di Stia al premio Casentino: da lì nacque un’amicizia, anche per la consonanza d’interesse per Leopardi come si può evincere da questa sua lettera: «Il suo secondo saggio, sul Risorgimento, è stato una rivelazione e mi ha soprattutto convinto». Sul significato di quell’antico sodalizio fiorentino e il “clima” che lo caratterizzò riporto le parole di Piero Bigongiari: «Non era assolutamente un clima “apertissimo” e, per essere obiettivi, non fu neppure un clima politico avente cioè un preciso indirizzo, visto che l’avversione al fascismo fu essenzialmente - salvo poche eccezioni - di carattere puramente culturale: contro la gonfia retorica e il provincialismo ("autarchico”) della letteratura del regime». E ora testualmente da un’intervista, che si trova su Il Portolano, Gennaio-giugno 1999, numeri 17/18: «Isolati come eravamo da una situazione politica che ci teneva all’oscuro della realtà, fu per noi naturale imparare a meditare sulle cose. Fu così che della letteratura scartammo l’aspetto superficiale - e con esso anche l’ossessione del successo, della notorietà - e ci aprimmo a un raggio di letture che allora erano rimaste, fra i letterati, senza eco. Il desiderio di approfondire portò con sé un uso più responsabile del linguaggio, e quindi un bisogno di scavo, punti di vista nuovi. Il nostro modo di esprimersi fu a volte improprio, sembrò oscuro - di qui l’accusa di oscurità - e forse lo era. Ma il fatto è che mentre le generazioni precedenti erano caratterizzate da una sorta di superbia, di nazionalismo culturale - preludio alla farsa dell’ “Italia imperiale” - noi accettavamo con umiltà l’insegnamento degli autori stranieri, e tra gli italiani si riscoprivano i meno conosciuti, e la realtà, i fatti umani, gli aspetti delle cose, ci apparivano piuttosto come problemi che come verità scontate e note da sempre».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








