Quei figli della Grande Guerra che nessuno voleva accettare
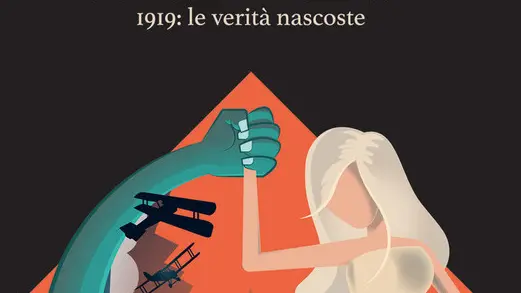
Li chiamavano “bastardi”, “much”. Per la Chiesa e la burocrazia erano “figli del peccato” o “del crimine”. Alla fine la definizione più efficace e umana risulterà quella di “orfani dei vivi”, ripreso dall’ultimo romanzo di Fabrizio Blaseotto (sottotitolo 1919: le verità nascoste) , centrato su una delle conseguenze della Grande guerra che afflisse il Nord Est: le tante nascite frutto di stupri o di una prostituzione necessitata dalla fame. Con questo libro edito da Aviani, lo scrittore cordovadese riannoda i fili della sua controstoria, ripartendo da “Gioventù spezzata”, e indaga su una realtà dolorosa e poco nota, i figli della guerra, rifiutati dalle famiglie quasi sempre per volontà del marito reduce dal conflitto.
Nel 1915 in Friuli, con i maschi chiamati alle armi, al fronte e nelle retrovie arrivarono soldati provenienti da altre regioni italiane, a centinaia di migliaia. Questa promiscuità, e le condizioni di bisogno diedero l’avvio a un fenomeno destinato a esplodere con Caporetto. Si teorizzò, allora, per salvaguardare la purezza della stirpe e l’onore dei combattenti in grigioverde, disonorati da un adulterio non importa se voluto o subito, persino il “dovere dell’aborto”. E quando la scrittrice Anna Franchi, convinta interventista, affermò sul “Popolo d’Italia” che la decisione sarebbe comunque dovuta toccare alle donne, venne tacciata di antipatriottismo, perché così si sarebbe favorita la presenza, nelle case, dei “bastardi dei tedeschi” (in realtà anche molti bastardi degli italiani, visto che nel luglio 1919 nel Triveneto erano ancora acquartierati 1.700.000 soldati).
Viene messa all’opera una commissione d’inchiesta sui “delitti contro l’onore femminile”, problema, ovviamente, dei capifamiglia. Di fronte ai militari che le interrogano, per vergogna, molte donne negano o ritrattano. Solo in 750 denunciano ufficialmente i fatti, che alla commissione interessano anche per farli valere economicamente al tavolo di Versailles. Al netto di aborti e infanticdi, rimane comunque un buon numero di illegittimi che non possono, in base alle norme vigenti, essere accolti negli orfanotrofi. Un sacerdote friulano, Celso Costantini (che poi diventerà cardinale) nel 1919 crea a Portogruaro un istituto, il “San Filippo Neri”, che ne accoglie 357. Metà non riuscirà a compiere un anno di vita. Dei restanti, grazie all’opera di convincimento dei sindaci, dei parroci, e a un piccolo sussidio riconosciuto, una parte viene riaccolta in famiglia. Ne rimarranno, alla fine, 57, affidati alla carità delle istituzioni.
Questa la robusta cornice storica in cui Blaseotto inserisce la sua storia, che racconta di Giacomo, sergente disertore dell’Alto But, che torna dall’Argentina, dove era fuggito durante la guerra, per cercare un nipote abbandonato.
È difficile capire dove finisca la realtà documentata e dove inizi la costruzione del romanzo. Ma la cosa ha scarsa importanza: i nessi logici ed emotivi della narrazione le danno una plausibilità piena, anche nell’intrico di una vicenda che racconta di ragazze passate dai bordelli voluti da Cadorna a quelli dell’Argentina dei migranti, di ex portatrici diventate “recuperanti”, assieme a ragazzi afflitti dalla miseria seguita alla vittoria, di disertori da più bandiere (traditori della guerra, più che di una nazione), sbandati in Russia o inquadrati nella “legione redenta”, dei primordi del “turismo bellico” in Friuli. —
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








