Riaffiora la storia dell’antico convento e le tracce di quei frati che parevano perdute
I domenicani a Cividale nel libro di monsignor Bruno Baccino. Scoperto il luogo preciso dove sorgeva il monastero
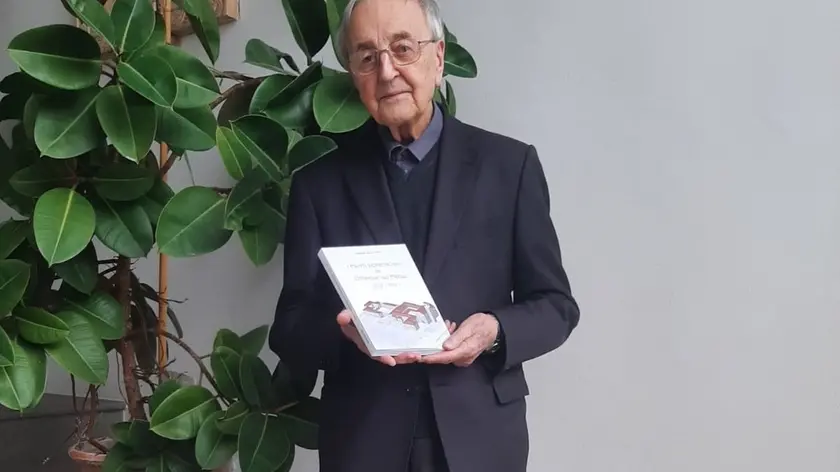
Una storia ormai sconosciuta, della quale si era persa completamente nozione nonostante la durata plurisecolare e l’apporto recato alla città ducale, riaffiora in tutte le sue articolazioni e sfaccettature grazie a un mastodontico lavoro di ricerca d’archivio condotto da un sacerdote novantaquattrenne, che ha restituito alla comunità cividalese - e regionale - una lunga, interessantissima pagina del suo passato.
Con un volume che verrà presentato al pubblico domani pomeriggio, alle 18, nella chiesa cittadina intitolata ai santi Silvestro e Valentino, in Borgo San Domenico, monsignor Bruno Baccino - parroco di Sanguarzo, Purgessimo e Carraria - spalanca una finestra sul ruolo rivestito in loco dai frati domenicani, insediatisi nel 1252 e rimasti a Cividale fino al 1810, data del decreto napoleonico che sancì la soppressione delle congregazioni religiose.
Sulla stessa collocazione del convento non c’era più certezza: «Quando ero bambino – racconta il monsignore – si credeva che la struttura si fosse sviluppata in adiacenza alla chiesa di Borgo San Domenico. Non era così».
Le indagini di don Baccino hanno infatti permesso di stabilire senza ombra di dubbio che l’antico e ampio complesso, di cui non restano tracce, sorgeva all’imbocco di via Borgo San Domenico (dunque, all’epoca della fondazione, subito fuori dalla cinta muraria d'epoca romana), nell’area in cui nei decenni scorsi c’era la sede dell’Enel.
Ad accendere in terra cividalese il fervore nei confronti dell’ordine domenicano era stato, nel 1242, tale fra Leonardo di Latisana, giunto nell’antica Forum Julii per predicare e divenuto in breve talmente celebre da essere invitato a parlare alle suore Benedettine, nel monastero di Santa Maria in Valle: e fu proprio lui, in quell’occasione, a scoprire sotto l’altare della chiesa di San Giovanni in Valle una cassa che, una volta aperta, rivelò le reliquie dei santi martiri aquileiesi.
Così forti furono l’eco e l’entusiasmo per la scoperta, oltre che per i sermoni di fra Leonardo, che prese corpo la volontà di favorire un insediamento dei domenicani sul territorio.
E dieci anni dopo, il 22 settembre del 1252, si arrivò - «nella casa di Palma de Portis», riferiscono le fonti archivistiche - alla firma del contratto di vendita di un ampio terreno alla confraternita, per costruirvi il convento: fu l’inizio di un’intensa attività religiosa ma pure sociale, perché i frati intesserono rapporti sempre più stretti con la comunità in cui si erano stabiliti, allargando i contatti fino alle Valli del Natisone, dove le predicazioni si estesero progressivamente; secoli più tardi (nel XVII) i frati domenicani attivarono anche una scuola e uno scriptorium.
Attorno al convento, nel frattempo, era nato un intero borgo (detto di San Domenico, toponimo tuttora in uso), che sotto il dominio veneziano venne inglobato all’interno di una nuova cerchia muraria.
Il ricchissimo materiale raccolto da don Baccino - fra l’archivio capitolare cividalese, quello di Udine e l’archivio di Stato, dove fra l'altro è stata individuata la pianta originaria del complesso conventuale - ha permesso di ricostruire che la comunità religiosa era composta da una trentina di frati, cui si affiancavano i novizi e varie persone di servizio.
Tante, nel tempo, le figure di spicco emerse da quella realtà, che al momento dello sgombero - in osservanza appunto alla legge napoleonica, che impose ai frati di tornare nelle città natali - fu acquistata in parti uguali, insieme ai terreni limitrofi, da Nicolò Zampari di Carraria, Luigi Orsaria e Francesco Sandrini.
Era il 7 gennaio 1811 e si chiudeva in via definitiva una tradizione lunga 558 anni: singolare, dunque, che «nelle strutture cittadine - è la chiosa dell’autore - non rimanga alcun segno della presenza dell’ordine domenicano, che nei secoli è stato fonte di fede e di cultura e ha espresso, nel Patriarcato, l’eccellenza di Forum Julii».
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








